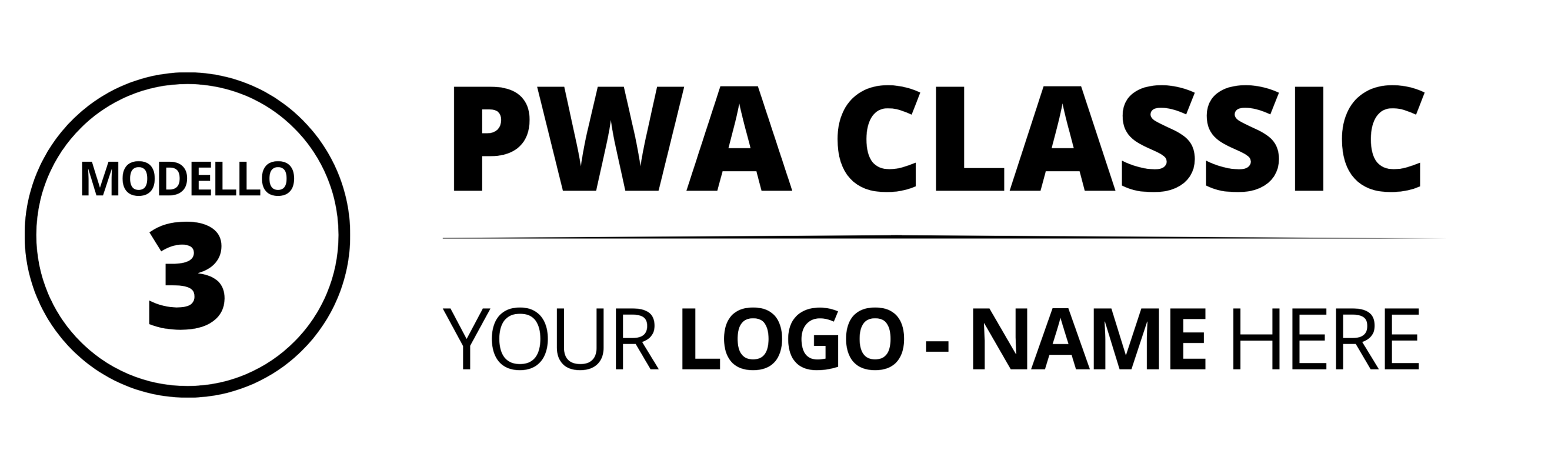Karl Marx, nel suo Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, descriveva con lucidità impietosa quel fenomeno per cui una società, illudendosi di accelerare il proprio cammino verso il progresso, si ritrova improvvisamente «ricacciata in un’epoca defunta». Un intero popolo, che credeva di aver conquistato con una rivoluzione una maggiore capacità di movimento, finisce per essere proiettato indietro, in un tempo morto, dove vecchi schemi si ripresentano sotto vesti nuove, ma altrettanto anacronistiche.
A Bologna, in occasione della Marcia della Pace del 1° gennaio 2025, abbiamo assistito a una riproposizione grottesca di questo meccanismo. Gli organizzatori hanno voluto a tutti i costi esibire sui manifesti e sul palco l’unità simbolica di «ebrei, cristiani e musulmani».
Un’immagine suggestiva, quasi fotografica, di concordia civile e religiosa: il cardinale, il sindaco, l’imam. A completare la scena, il rabbino.
A Bologna esistono tre comunità ebraiche distinte – ortodossa, chabad e progressiva – con tre rabbini radicati nel tessuto della città, che partecipano al dialogo interreligioso con serietà e responsabilità. Eppure, nessuno è stato interpellato.
È significativo che, per completare questo quadro di unità, si sia scelto di invitare un rabbino americano, Jeremy Milgrom, residente a Tel Aviv e noto, come emerge dai suoi interventi pubblici, per le sue posizioni estremiste nel panorama pacifista, senza nemmeno informare le comunità ebraiche locali. Si è preferito un ospite estraneo, sconosciuto alle nostre realtà, pur di avere sul palco una voce ebraica che dicesse esattamente ciò che si voleva sentire: accuse di «genocidio» a Gaza, distinzioni tra «buoni» e «cattivi» ebrei, e un antisionismo presentato come ovvia verità morale.
Il risultato? Una rappresentazione caricaturale dell’ebraismo bolognese, ridotta a mero ornamento scenografico.
Come un tempo la Democrazia Cristiana utilizzava le chiese e il clero cattolico come serbatoi di consenso elettorale – convinta che la fede potesse essere irreggimentata in blocchi di voti docili e prevedibili –, così oggi una certa sinistra sembra illudersi che le comunità religiose minoritarie, in particolare quella musulmana in crescita demografica, possano diventare «riserve di voti» affidabili. E per legittimare questa operazione, serve l’alibi dell’unità interreligiosa: basta mettere in locandina un ebreo, un cristiano e un musulmano, e il quadro è completo. Poco importa se l’ebreo invitato non rappresenti nessuno se non se stesso e le sue posizioni minoritarie; poco importa se le comunità locali vengano bypassate, umiliate nel loro ruolo di interlocutori autentici.
Norberto Bobbio ha ricordato più volte che la distinzione tra destra e sinistra non risiede nelle parole che si usano o nelle cause che si proclamano, ma nel modo in cui si esercita il potere e nel rapporto che si instaura con l’autonomia degli individui e dei corpi intermedi. Da questo punto di vista, la riduzione delle comunità religiose a elementi decorativi di una messa in scena politica segnala una regressione: al posto dell’emancipazione prevale l’uso strumentale, al posto dell’ascolto una logica di legittimazione che sostituisce l’autonomia delle comunità con una rappresentanza scelta dall’esterno.
La società italiana, e bolognese in particolare, è profondamente cambiata rispetto all’Italia del dopoguerra. Non siamo più in un Paese monoculturale, dove una Chiesa capillare poteva garantire fedeltà elettorali. Le comunità musulmane sono eterogenee, frammentate, e – come dimostrano esperienze europee e casi italiani recenti – non si lasciano catturare stabilmente da partiti laici. Le comunità ebraiche, dal canto loro, sono plurali, consapevoli della propria storia e gelose della propria autonomia: non accettano di essere usate come sigillo di approvazione per agende politiche unilaterali.
Questa Marcia della Pace, che pure ha visto qualche persona in buona fede scendere in piazza, ha finito per rivelare un anacronismo profondo: l’illusione che il dialogo interreligioso possa essere orchestrato dall’alto, selezionando voci compiacenti e marginalizzando quelle autentiche.
Theodor W. Adorno aveva messo in guardia contro una delle illusioni più persistenti della modernità: l’idea che ciò che si presenta come emancipazione lo sia automaticamente. Quando il linguaggio del progresso smette di interrogare i propri effetti reali, può trasformarsi in una forma di dominio esplicita, che opera per semplificazione e per imposizione simbolica, senza avvertire il bisogno di giustificarsi. È in questo senso che operazioni come quella messa in scena a Bologna appaiono anacronistiche: non perché arretrate nei valori dichiarati, ma perché riattivano logiche di strumentalizzazione che la storia avrebbe dovuto archiviare.
La pace non si costruisce con fotografie di maniera o con palchi costruiti ad arte. Si costruisce nel rispetto reciproco, nella consultazione reale, nel riconoscimento che nessuna comunità può essere ridotta a trofeo simbolico. Bologna, città di antica tolleranza, merita di più. Merita un dialogo che parta dal basso, non da operazioni di immagine che, alla fine, dividono più di quanto uniscano.
E forse, parafrasando ancora Marx, la storia si ripete: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. Speriamo che non ci sia una terza.